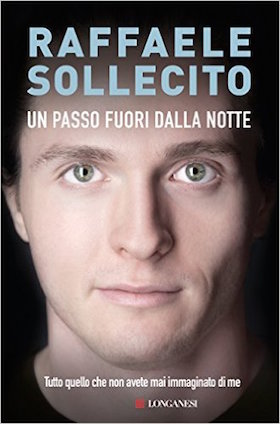


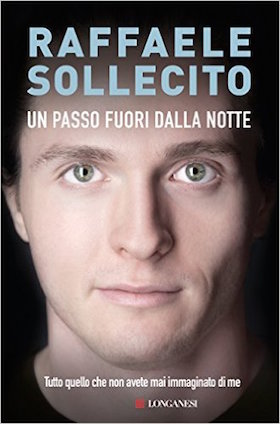
Senza dubbio il famigerato “delitto di Perugia” - ossia l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, aggredita a novembre del 2007 all’interno dell’abitazione che condivideva con altre ragazze nel capoluogo umbro – può essere considerato da un lato uno dei casi più seguiti dal pubblico negli anni recenti, che ha appassionato e diviso l’Italia e il mondo, e dall’altro un fenomeno mediatico che probabilmente ha segnato l’apice di quel percorso di spettacolarizzazione dei fatti di cronaca nera, affermatosi tetramente specie nel nostro paese, le cui implicazioni in fase processuale sul destino degli accusati in generale sono tuttora da valutare.
Ci sono voluti infatti cinque gradi di giudizio e quattro lunghissimi anni di carcerazione preventiva per arrivare ad una sentenza definitiva che solo nel 2015 ha stabilito definitivamente l’estraneità dei due imputati rispetto ai fatti contestati restituendoli alla vita civile. Ma non ad un anonimato rassicurante, reso impossibile sul breve periodo dall’estenuante tritacarne messo in opera dai mass media senza alcun rispetto del lutto dei congiunti della vittima, delle esigenze investigative certamente ostacolate dall’ininterrotto e morboso clamore e soprattutto della necessaria presunzione d’innocenza degli imputati fino alla conclusione del processo in tutti i suoi gradi.
Recentemente è stata la piattaforma americana Netflix a ritornare sull’argomento con un documentario straordinario e scioccante, dal titolo programmatico e lapidario di “Amanda Knox”, che tenta di ricostruire la vicenda attraverso le parole dei protagonisti inframezzate da lunghi spezzoni di repertorio e, pur non esprimendo una tesi a priori sul caso in sé, riesce ad attrarci nel vortice repentino degli eventi in cui tutti – imputati, inquirenti, giornalisti – si dibattono senza avere apparentemente alcun margine di controllo della situazione.
Se va riconosciuto a Rob Blackhurst e Brian McGinn, autori del docufilm, un merito particolare, è quello di porgerci uno strumento per scrutare in tutta sicurezza dentro l’abisso, che tuttavia per sua stessa natura risponde sempre al nostro sguardo penetrandoci l’anima, lasciandoci dentro una sensazione di gelida angoscia all’idea che, sì, allo stato delle cose, dal punto di vista giudiziario e mediatico, potrebbe capitare a chiunque di noi di ritrovarsi in una situazione del genere. Ed è soprattutto lo sguardo di Amanda, distante ed agghiacciato, perso altrove, nonostante le lacrime, a trasmetterci lo strazio dell’accusato che continua ad essere perseguitato dai suoi demoni. Sempre gli stessi, dai roghi di Salem ad oggi.
Forse l’unico pensiero consolante è che quei demoni si può sempre combatterli, rinchiuderli in una dimensione razionale, dove perdono ogni potere sulle singole vite e sembra che sia Amanda che Raffaele, su percorsi paralleli, lo stiano facendo proprio impegnandosi perché non si ripeta per altri il loro stesso calvario o comunque perché si apra una seria riflessione sui meccanismi che sottostanno all’elevazione di moderne “colonne infami”.
Amanda al momento lavora come giornalista freelance a Seattle e collabora con un’associazione che si occupa proprio dell’assistenza alle vittime di malagiustizia. Ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro l’Italia, per iniquo processo e maltrattamenti, ed è notizia recente che Strasburgo l’ha accolto seppure in via preliminare.
Raffaele invece poco dopo l’assoluzione definitiva s’è iscritto al Partito Radicale e, mentre lotta per ottenere dallo Stato un risarcimento per ingiusta detenzione che coprirebbe a malapena la metà delle spese affrontate per il processo, si dichiara totalmente coinvolto nell’obiettivo sociale di informare e far conoscere al grande pubblico l’oscuro mondo delle prigioni italiane, con i loro meccanismi interni ignoti, le regole non scritte, tutto il bagaglio d’afflizione caratteristico d’un’esperienza totalizzante come il carcere che, spesso, continua a pesare su chi la subisce – non importa se colpevole o innocente – pure dopo l’assoluzione o la fine naturale della pena.
Lo scorso 15 ottobre presso l’Abitart Hotel a Roma, nel quartiere Testaccio, nell’ambito d’una presentazione del libro edito da Longanesi “Un passo fuori dalla notte” in cui racconta la sua vicenda, abbiamo potuto di nuovo sentire la viva voce di Sollecito – dopo il suo accorato intervento nell’ambito del congresso straordinario del PRNTT a Rebibbia – descrivere realtà inimmaginabili, fornire sprazzi di consapevolezza dolorosa che sembrano per l’appunto squarciare la coltre d’ignoranza colpevole e cupa che s’addensa su chi si trova suo malgrado a vivere certe esperienze.
Fa una certa impressione guardare ed ascoltare Raffaele mentre rievoca con un accento morbido, quasi monocorde nella sua linearità, spesso fissando negli occhi qualcuno degli intervenuti nelle prime file, l’inizio dell’incubo, la scoperta del corpo di Meredith e poi l’improvvisa discesa nell’atroce ed annoso maelstrom affrontato con Amanda, prima, poi da solo, rinchiuso, con echi della bagarre mediatica provenienti dall’esterno che, nella cella d’isolamento, hanno certamente contribuito non poco ad accentuare per lui l’atmosfera d’alienazione e dissociazione dalla realtà che è, di suo, un tratto peculiare della detenzione.
Ed è particolarmente duro l’atto d’accusa finale alla società con cui Raffaele conclude il suo intervento, quando sottolinea come di fatto non si senta riabilitato né, durante gli anni tremendi della custodia cautelare e del processo, si sia sentito assistito, seguito dall’istituzione-carcere, che vuoi per ragioni politiche, vuoi per la cronica mancanza di fondi o per queste ed altre cause tra loro correlate, abbandona a sé stesso il detenuto. Prima, durante e soprattutto dopo quest’esperienza, quando si ritrova a confrontarsi con una sorta di marchio d’infamia che rende particolarmente difficoltoso il suo rientro nel consesso civile.

Ed è qui che risalta l’importanza di eventi come questo, organizzato da Crime Box, un’associazione guidata dalle giovani criminologhe Marica Palmisano e Maria Elena Caporale – quest’ultima specializzata proprio nel reinserimento sociale degli ex-detenuti – che non vuol limitarsi a fornire al pubblico uno spaccato inedito d’indubbia utilità grazie anche alla collaborazione con Raffaele, ma si presenta con una proposta attiva, decisamente valida: creare una rete formata di volontari, figure professionali come legali, psicologi, ecc. che intervenga proprio sull’isolamento e spesso l’ignoranza di doveri e diritti in cui molti soggetti si dibattono all’interno degli istituti, per contribuire fattivamente alla loro riabilitazione.
E questo non solo per alleviare questo senso d’alienazione mentre sono “dentro”, ma anche e soprattutto per accompagnarli in un percorso d’autocoscienza che permetta un autentico reinserimento “fuori”. Le ragazze cercano collaboratori ed un augurio di buon lavoro ci sembra a questo punto doveroso mentre, da Radicali, ci preme ricordare che, con tutto l’apprezzamento per l’impegno inestimabile dei volontari, continuiamo a ritenere che l’annoso problema delle carceri debba essere affrontato dallo Stato, magari a partire da quell’ormai improrogabile provvedimento di amnistia richiesto senza sosta da Marco Pannella e per cui il Partito Radicale il 6 novembre sfilerà a Roma. Speriamo di rincontrare alla marcia anche Raffaele Sollecito.
Gianni Carbotti
(foto di Gianni Carbotti)


|
é uscito il N° 119 di Quaderni Radicali "EUROPA punto e a capo" Anno 47° Speciale Maggio 2024 |

|
è uscito il libro Edizioni Quaderni Radicali ‘La giustizia nello Stato Città del Vaticano e il caso Becciu - Atti del Forum di Quaderni Radicali’ |

|
è uscito il libro di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo "Napoli dove vai" |

|
è uscito il nuovo libro di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo "l'altro Radicale disponibile |