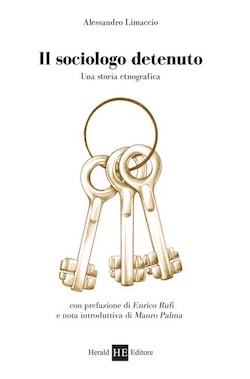


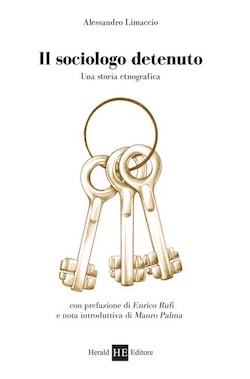
Il sociologo detenuto. Una storia etnografica (Herald Editore) è un libro di Alessandro Limaccio. L’autore è in carcere - come riporta la quarta di copertina - dal 1995, quando aveva 23 anni. Condannato a quattro ergastoli ostativi per cinque omicidi dei quali si è sempre proclamato innocente… Può vantare due primati: è il primo detenuto in Italia ad aver conseguito un dottorato di ricerca in sociologia dietro le sbarre nel 2017, ma anche il primo detenuto in Italia a rifiutarsi di chiedere permessi per poter proclamare con più forza la propria innocenza. Quella che segue è la prefazione di Enrico Rufi, redattore di Radio Radicale con un dottorato in Letteratura francese alla Sorbona…
“Dopo più di cinque lustri - scrive Rufi -, il Sociologo embedded in quella periferia del mondo che è l’universo carcerario italiano ha bruciato ogni record di durata di un’inchiesta etnografica sul campo, tutta vissuta in comunione con la sua gente, come facevano certi missionari-antropologi dei secoli scorsi. È ora di chiudere il capitolo, perché c’è un tempo per ogni cosa. Con questo libro, offerto alla comunità scientifica, agli addetti ai lavori, ai suoi compagni e alla società civile, missione compiuta…
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Prefazione
di Enrico Rufi
Presumo che più d’uno siano i sociologi finiti nelle patrie galere, non necessariamente nei cosiddetti anni di piombo, ma uno solo è diventato sociologo in carcere. Prima con la laurea, poi con un dottorato, rilasciato nel 2017 dall’università di Roma ‘‘La Sapienza’’. E adesso, sociologo ‘‘embedded’’, con questo reportage dai vari gironi del mondo carcerario italiano. Proprio per questo suo primato, nel 2018 il Sociologo detenuto è stato insignito del premio nazionale alla cultura «Sulle ali della libertà», premio promosso dall’associazione di ispirazione cattolica «L’isola solidale», sotto l’Alto patrocinio della Presidenza della Repubblica. Si chiama Alessandro Limaccio, è siciliano, classe 1971, quattro ergastoli per cinque omicidi. di Enrico Rufi
Presumo che più d’uno siano i sociologi finiti nelle patrie galere, non necessariamente nei cosiddetti anni di piombo, ma uno solo è diventato sociologo in carcere. Prima con la laurea, poi con un dottorato, rilasciato nel 2017 dall’università di Roma ‘‘La Sapienza’’. E adesso, sociologo ‘‘embedded’’, con questo reportage dai vari gironi del mondo carcerario italiano. Proprio per questo suo primato, nel 2018 il Sociologo detenuto è stato insignito del premio nazionale alla cultura «Sulle ali della libertà», premio promosso dall’associazione di ispirazione cattolica «L’isola solidale», sotto l’Alto patrocinio della Presidenza della Repubblica. Si chiama Alessandro Limaccio, è siciliano, classe 1971, quattro ergastoli per cinque omicidi.
A scanso di equivoci, la sua non è una edificante vicenda di riscatto o di riabilitazione attraverso lo studio. Lui non deve restituire niente alla società. È la società che deve restituire tutto a lui: l’onore e venticinque anni di vita, che gli sono stati tolti in nome del popolo italiano. Ma siccome sulle sue condanne c’è scritto «fine pena mai», il debito nei confronti del sociologo detenuto diventa più pesante ogni giorno che passa. Tecnicamente, per l’Amministrazione penitenziaria non venticinque ma trentuno sono gli anni di detenzione ininterrotta che ha finora scontato.
Io ho conosciuto Alessandro tre anni e mezzo fa. Volevo abbracciare le persone che pochi mesi prima dal reparto G8 del carcere di Rebibbia, qui a Roma, avevano scritto una fraterna lettera di vicinanza e consolazione alla mamma, alla sorella e al papà dell’unica ragazza che non era tornata dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia del 2016, fulminata dalla meningite sulla via del ritorno. Perché nessuno più di chi sconta una lunga pena detentiva è in grado di capire la pena che sconta chi perde per sempre una figlia o una sorella. È attraverso mia figlia Susanna, quindi, che ho conosciuto Alessandro.
Un giorno Alessandro mi disse: «Indovina con chi ero a cena ieri sera»? Beh, aveva cenato col Presidente della Repubblica. Del resto quattro anni prima aveva anche incontrato papa Francesco, al quale aveva raccomandato la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, perché il nostro sociologo è cattolicissimo, devoto come pochi alla Madonna di Fatima, e prima ancora aveva potuto incontrare papa Ratzinger, oltre al cardinal Sepe.
Sergio Mattarella era stato invitato a cena all’Osteria degli uccelli in gabbia, ristorante all’interno del carcere di Rebibbia, gestito da detenuti. Mantecato di baccalà e patate con polvere di taggiasche, gnocchi alla romana di semolino gratinati al pecorino con amatriciana di pesce spada, tortino di spigola con purea di ceci, porcini secchi e finferli, cheescake ai lamponi con crema allo Strega, seguito da un caffé galeotto. Della tavolata faceva parte anche il Ministro della Giustizia, il Garante nazionale dei detenuti e la direttrice del carcere, oltre ad altri detenuti, ma a reggere la conversazione col Presidente ci pensò soprattuto il dottore in sociologia, cui non a caso era stata riservata una collocazione strategica a tavola, obliquamente rispetto al Presidente, a pochi posti di distanza.
A un certo punto il Sociologo detenuto provocò un momento di apprensione fra i commensali, quando rivolto al corregionale Mattarella disse: «Presidente, lei ed io non abbiamo in comune solo la Sicilia. Indovini che cos’altro?» La risposta esatta era: la Democrazia Cristiana, ma Mattarella non ci arrivò da solo, né i presenti riuscirono ad aiutarlo. Non solo, si trovarono esclusi dalla conversazione quando Alessandro, evocando le vicende dello scudo crociato in Sicilia, rese omaggio alla figura di Bernardo, papà di Sergio e Piersanti, nonché deputato DC alla Costituente e più volte ministro della Repubblica, ma si accorsero tutti che il Presidente era commosso.
***
Pur non essendosi mai tesserato, Alessandro era stato un attivista in gioventù. Sicuramente fu molto attivo nella campagna delle amministrative del 1989, del 1990 e del 1992 a Lentini, nel siracusano, e forse determinante per far eleggere un sindaco democristiano – Antonino Mazzone, suo insegnante di stenografia - dopo un’amministrazione di sinistra, 1991, vista l’influenza che aveva tra i suoi coetanei, essendo stato eletto rappresentante degli studenti al suo Istituto Tecnico Commerciale.
A Lentini, dove Alessandro è cresciuto, e dove duemilaquattrocento anni prima era nato il principe dei sofisti Gorgia e ottocento anni prima l’inventore del sonetto Jacopo da Lentini, la famiglia Limaccio gestiva un piccolo bazar. All’epoca Lentini, cittadina barocca circondata da agrumeti a una dozzina di chilometri dal mare, contava oltre 27000 abitanti. Oggi sono circa 22000. L’arresto del giovane Limaccio fece scalpore, lasciò perplessi i suoi concittadini, ai quali non risultava che quel ragazzo di sana famiglia fosse affiliato a clan mafiosi, o che bazzicasse quegli ambienti. Eppure le gesta criminali che gli vengono attribuite fanno di lui non un killer assoldato all’occorrenza, un comodo insospettabile ‘‘monouso’’ per così dire, ma un picciotto regolarmente inquadrato nei ranghi di un clan mafioso. In casa sua si credeva nelle istituzioni.
Si simpatizzava per il PCI, partito ben radicato a Lentini, ma durante le scuole superiori il giovane Alessandro scoprì l’anticomunista che era in lui. Da cattolico apostolico romano la scelta era obbligata. Dalla perquisizione della sua abitazione, con cui nell’autunno del 1991 si inaugurò l’accanimento della Giustizia contro il giovane Limaccio, non vennero fuori né lupare né droga, ma solo materiale elettorale della DC, i ‘‘santini’’ del candidato sindaco, corrente andreottiana.
Nessuno toglie dalla testa ad Alessandro che la sua vicenda giudiziaria nasce, si sviluppa e si spiega all’interno delle dinamiche che avrebbero portato al processo per mafia Giulio Andreotti. Certo è che in quel clima vanno contestualizzati i suoi quattro ergastoli. Che fanno acqua da tutte le parti. È stato condannato come killer di mafia un ragazzo che all’epoca aveva vent’anni e che era estraneo, lui e la sua famiglia, ad ambienti e cultura mafiosi. Per lui il ‘‘welfare mafioso’’ non è mai scattato, neanche con l’assistenza legale. Si è appreso di recente che a distanza di trentacinque anni gli assassini di Giancarlo Siani, il giornalista napoletano trucidato venticinquenne a Napoli nel 1985, ricevono ancora la ‘‘mesata’’ dalla camorra in carcere.
Loro e pure le loro famiglie. Se poi si aggiunge che le condanne sono state determinate da pentiti senza scrupoli, senza prove, nell’ambito di maxiprocessi dove tutti gli imputati sono stati condannati all’ingrosso, oltre che da varie leggerezze, disinvolture, storture e incongruenze processuali, e pure che mai nessuno si è costituito parte civile contro di lui, le probabilità che il Sociologo sia non solo ingiustamente, ma anche indecentemente detenuto non si fondano solo sulla sua indefessa proclamazione di innocenza, di estraneità.
Che comunque va al di là delle sue rivendicazioni, perché è testimoniata, corroborata da un sistematico rifiuto di chiedere ogni beneficio, ogni misura alternativa, ogni permesso, ai quali da ben nove anni Alessandro potrebbe accedere. Se solo lo volesse. Ma, dice lui, un innocente non deve chiedere niente, «l’innocenza non si patteggia». E infatti ha perfino rifiutato di uscire dal carcere per ritirare il premio di cui si è detto. Un innocente non deve chiedere clemenza, né accettare la logica della redenzione e del recupero del detenuto, perché quello vale per i colpevoli. Tanto meno è disposto a chiedere la grazia.
C’è probabilmente un altro ingrediente che può aver contribuito in modo determinante a mettere nei guai il giovane Limaccio: la vendetta. La vendetta da parte di un marito tradito, che aveva subito l’umiliazione di veder la moglie quarantenne scappare con quel ventenne aitante e intraprendente, lui che era uno degli uomini più potenti nelle istituzioni a Catania. Uomo di sinistra, ci tiene a sottolineare il Sociologo, che però non ha mai voluto fare il nome della donna per tutelarla, né, conoscendolo, mai lo farà. Il giorno dopo la fuga d’amore a Roma, il 5 ottobre del 1991, venne perquisita l’abitazione dei Limaccio.
Meno di un anno dopo, luglio 1992, per festeggiare l’elezione del nuovo sindaco di Lentini, Alessandro parte per qualche giorno in vacanza con un vecchio compagno di scuola. Vicino Caserta strano posto di blocco della polizia stradale, strana e rapida perquisizione della macchina (comunque non di proprietà di Alessandro) e strano rinvenimento di una pistola con silenziatore e matricola abrasa. A questo fa seguito poche ore dopo una strana telefonata anonima e molto informata, silenziatore e matricola compresi, al 113 di Catania per accusare i due amici di essere gli autori dell’omicidio di un ispettore di polizia, avvenuto il giorno prima a Catania.
Ma questo sarebbe uscito fuori solo anni dopo, per caso, nell’ambito di un processo che non riguardava Alessandro Limaccio. E comunque, quella volta ci fu un assassino reo confesso per fortuna. Il sospetto è più che legittimo che l’autore della telefonata anonima possa essere stato lo stesso ad aver messo la pistola sotto il sedile della macchina. Processo con rito abbreviato per l’attivista democristiano, condanna a un anno e dieci mesi con pena sospesa. Ma intanto era diventato un pregiudicato. Era entrato nel tritacarne. La strada era spianata per scaricare all’occorrenza su di lui la responsabilità di qualche delitto di mafia in cerca di autore.
La via crucis del Sociologo detenuto non è fatta solo di telefonate anonime, ma anche di ‘‘voci confidenziali’’, oltre che di pentiti e pseudo pentiti. Si badi bene: i collaboratori protagonisti dei processi di Alessandro Limaccio non si autoaccusano mai, non sono mai presenti sui luoghi dei delitti, ma riferiscono voci e accuse raccolte qua e là nella migliore delle ipotesi. È una voce confidenziale, ad esempio, quella secondo cui il killer – un certo Sandro diventato attraverso una serie di progressivi aggiustamenti di tiro Alessandro Limaccio - era stato visto salire in macchina con un boss mafioso poco prima che quest’ultimo venisse assassinato.
Con una dinamica ufficiale del delito così rocambolesca, con tanto di salto dalla machina in corsa un attimo prima che finisse in un dirupo e un attimo dopo che la vittima ricevesse un colpo di pistola alla tempia, da lasciare perplesso anche uno stuntman. Voce confidenziale non solo indebitamente usata, perché inammissibile come accertamento della responsabilità penale nei confronti dell’imputato, ma finita addirittura nero su bianco nella sentenza che avrebbe portato al primo ergastolo per Alessandro Limaccio. Con buona pace dell’alibi dell’accusato e dell’esame autoptico del medico legale, che collocava la morte della vittima prima dell’avvistamento in macchina col giovane Limaccio, ormai suo assassino ufficiale dopo il pronunciamento della Cassazione.
Anche in quegli anni, nonostante la vicenda di Enzo Tortora, i giudici facevano tranquillamente carriera a prescindere dai danni che provocavano, sapendo di poter contare sul sostegno del Consiglio Superiore della Magistratura. Quello stesso CSM che ormai l’opinione pubblica ha imparato a conoscere meglio grazie alle intercettazioni del giudice Palamara.
Se Marco Pannella non avesse fatto quello che Émile Zola aveva fatto con Alfred Dreyfus, il galantuomo di Portobello indicato dai collaboratori come un grossista senza scrupoli di eroina e cocaina, non avrebbe avuto scampo: chissà quanti avanzi di galera si sarebbero riciclati collaboratori di giustizia approfittando di quel capro espiatorio per accreditarsi e ottenere sconti e privilegi, se non impunità.
Alessandro Limaccio non era neppure ventunenne all’epoca, ma per lui la giovane età non è stata fatta valere dai giudici, a differenza di altri coimputati coetanei, condannati per omicidio, a cui è stato risparmiato l’ergastolo. Non solo nessuno sconto, ma addirittura le aggravanti. Benché pluripregiudicati e di età compresa tra i trentacinque e i quarantacinque anni, i due co-killer condannati insieme ad Alessandro Limaccio si videro infliggere pene inferiori ai trent’anni.
Quella volta, stando alla verità processuale, Alessandro Limaccio faceva parte di un vero e proprio commando di quattro sicari, che travestiti da carabinieri citofonarono a casa della vittima designata, invitandola a scendere per un controllo. Lo crivellarono di colpi sotto gli occhi della moglie dopo averlo ammanettato. Affacciata al balcone, la donna vide tutto. Ma non riconobbe ‘‘il Limaccio’’.
Era intanto entrato in scena – siamo nel maggio del 1999 - un altro ‘‘pentito’’. Incoraggiato dalla soddisfazione dei magistrati, il collaboratore consiglia al fratello minore (a rischio vendetta trasversale per essere fratello di ‘‘pentito’’) di seguire le sue orme diventando anche lui collaboratore e ottenere protezione. Non potendoci parlare direttamente, visto che erano detenuti in carceri diverse, pensa bene di dare al fratello indicazioni scritte sugli omicidi da attribuire anche lui ad Alessandro Limaccio. Nonostante la sconcertante documentazione epistolare sia stata prodotta nel dibattimento al processo, i giudici non vollero rinunciare a un colpevole offerto su un piatto d’argento, e così Alessandro Limaccio si ritrovò sulle spalle altri quattro omicidi.
I giudici non hanno consentito neppure ai testimoni oculari di dare una mano al povero Limaccio. Non solo la donna che aveva visto trucidare il marito affacciata al balcone. Anche un prete e un carabiniere fuori servizio non avevano riconosciuto Limaccio nel killer che in pieno giorno aveva sparato in uno stabilimento balneare del litorale siracusano. L’omone alto di statura, capelli lunghi e «faccia da indiano» poco e niente aveva a che vedere con Alessandro Limaccio, magro, un metro e settantadue, occhi azzurri, carnagione chiara e capelli corti e chiari, ma fu data credibilità al collaboratore di turno piuttosto che ai testimoni oculari. Certo, ad Alessandro avrebbe fatto comodo disporre di qualche alibi di ferro, ma chi è in grado di dire dove si trovava, con chi e che cosa faceva un determinato momento di un determinato giorno di sette anni prima?
Telefonate anonime, voci confidenziali, pentiti, pseudopentiti, ma anche giudici ricorrenti e intercambiabili. Si prenda Francesco Aliffi: giudice a latere nella Corte d’Assise di Siracusa che aveva condannato Alessandro Limaccio al primo ergastolo nel procedimento ‘‘Tauro’’ ; pubblico ministero nel procedimento ‘‘San Marco’’ che comminò tre ergastoli al futuro sociologo per i quattro omicidi appena citati. Ma si prenda anche Francesco Mannino, GIP (giudice per le indagini preliminari) quando firmò l’ordinanza di custodia cautelare , GUP (giudice dell’ udienza preliminare) undici mesi dopo quando nello stesso procedimento firmò il rinvio a giudizio il 27 maggio del 1996.
Passiamo al Presidente della Seconda sezione della Corte di Cassazione, Antonio Morgigni, che doveva pronunciarsi sul procedimento ‘‘Tauro’’ (il primo ergastolo per Alessandro Limaccio). Il togato esordì con queste parole: «Ho studiato molto bene questo processo e devo dire che sono stati travisati gli atti. Ho intenzione di porvi rimedio». Conferenza stampa, a seguire, dell’avvocato Carlo Taormina (difensore dell’imputato Nardo): «Questo procedimento ‘‘Tauro’’ non doveva arrivare neanche al primo grado di giudizio, invece ci troviamo in Cassazione grazie a quei magistrati che mi accusano di difendere i mafiosi, quando invece sono loro che esercitano la funzione di magistrati usando metodi mafiosi». Provvidenziale, intervenne subito dopo uno sciopero dei magistrati indetto dalla solita ANM.
La Corte ritardò così alcuni giorni a ritirarsi in camera di consiglio, e quando ne uscì confermò in toto la sentenza d’appello. Nessuno si meravigli se si fece strada tra gli avvocati difensori la convinzione che nel frattempo la Corte aveva ricevuto pressioni potenti dall’interno di zone oscure degli apparati dello Stato. Del resto, stando alle recenti rivelazioni di finite sulle prime pagine dei giornali, pare proprio che la Corte Suprema di Cassazione non sempre sappia, o non abbia sempre saputo resistere a pressioni ‘’dall’alto’’…
Nel luglio del ’94, ventiduenne, il futuro Sociologo era partito all’avventura per gli USA. Destinazione Miami, Florida. Qualche lavoretto, più che altro nell’ambito dell’import-export e soprattutto qualche aiuto da casa per sbarcare il lunario, e dopo undici mesi volo di ritorno, con l’intenzione comunque di non rinunciare al sogno americano e di ripartire al più presto. Sogno infranto, perché il giovane Limaccio viene arrestato pochi giorni dopo essere sbarcato in Sicilia, accusato, insieme a un centinaio di persone mai conosciute di associazione di stampo mafioso, articolo 416 bis del codice penale. Procedimento ‘’Tauro’’.
Eppure nessun problema c’era stato per rilasciare il passaporto al futuro arrestato. Rientro in patria a dir poco intempestivo e imprudente, se solo Alessandro avesse potuto immaginare che cosa lo aspettava. Incoscienza giovanile o semplicemente coscienza pulita? Per rispondere, aiuta sapere che erano entrati in scena i collaboratori di giustizia. Uno di questi lo riconosce in un album di foto segnaletiche mostrategli dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania.
Una foto di un improbabile Alessandro Limaccio capellone, che non ci fu modo di acquisire agli atti durante il dibattimento del procedimento ‘‘Tauro’’ nonostante le reiterate richieste avanzate dalla difesa. Solo dieci anni dopo, nel corso di un altro procedimento (processo d’appello ‘‘San Marco’’) si riuscì ad acquisire la foto, e si poté accertare che la foto cui aveva fatto riferimento il collaboratore chissà chi ritraeva. Non certo ‘‘il Limaccio’’, che nella foto acquisita aveva i capelli corti, né altre sue foto segnaletiche esistevano, visto che la documentazione trasmessa ai giudici era accompagnata da queste parole: «Non sono state rinvenute altre foto del Limaccio».
Il collaboratore in questione è lo stesso che nel processo di Palermo contro Giulio Andreotti verrà utilizzato dall’accusa per sostenere la mafiosità del Senatore a vita, ma il Tribunale lo riterrà non attendibile. In precedenza, un altro collaboratore, Leonardo Messina, uomo d’onore della famiglia mafiosa di Gela, aveva accusato Andreotti di essere stato ‘pungiuto’, cioè battezzato uomo d’onore, citando il boss di Lentini Sebastiano Nardo, il boss del clan del quale venne accusato di far parte Alessandro.
Quello citato anche nel film di Sorrentino Il Divo. Ipotesi dell’allora imputato, poi condivisa dal Sociologo detenuto: volevano indurmi a pentirmi per accusare Andreotti. Tanto per dare qualche coordinata, il clan Nardo faceva riferimento a Nitto Santapaola, il capo di Cosa Nostra di Catania. Ci sarebbe, a dirla tutta, pure un altro collaboratore di giustizia che prese di mira Alessandro Limaccio, evocando una presunta socializzazione in carcere nel 1992. Ma in quel caso fu facile dimostrare che all’epoca Alessandro non era detenuto. In carcere ci sarebbe entrato tre anni dopo, a Catania.
Errori giudiziari? Giustizia all’ingrosso? Uso spregiudicato dei collaboratori di giustizia? Complotto giudiziario-politico? Difesa inadeguata? Vendetta andata fuori controllo? Un mix di tutto questo, probabilmente. Per arrivare a condannare un innocente basta spesso uno solo di questi ingredienti.
***
Conviene essere colpevoli se si è condannati col fine pena mai. Almeno un modo per sottrarsi all’ergastolo c’è, anche se spesso non è praticabile perché si rischia di mettere in pericolo i propri famigliari: ‘‘pentirsi’’, diventare cioè collaboratori, dando nomi e informazioni utili ai giudici per le loro indagini. In realtà un modo sicuro, infallibile, ci sarebbe, eccome, ed è la Costituzione, che all’articolo 27 dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Ma uno che è stato condannato senza aver commesso il fatto, estraneo per di più all’ambiente in cui il delitto si è consumato, di che cosa può pentirsi? Che nomi e che informazioni può fornire, che servigio può rendere alla Giustizia? La Giustizia italiana, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha quindi a maggior ragione il dovere di trovare una via d’uscita per il Sociologo detenuto, che non solo non ha alcuna possibilità di ‘‘collaborare’’, ma che mai chiederà clemenza. Il dovere, ma anche la convenienza, perché il caso Limaccio sta ormai diventando imbarazzante.
Per trarsi d’impaccio si faccia aiutare, il DAP, dalla Corte Costituzionale, applicando la recente sentenza che ha rimesso mano al cosiddetto ergastolo ostativo pronunciandosi a favore della possibilità di ottenere permessi premio. Si faccia aiutare dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, adeguandosi subito al suo recente pronunciamento con cui ha bocciato l'ergastolo ostativo, perché viola l’articolo 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, l’articolo che vieta «trattamenti inumani e degradanti».
Si faccia aiutare dal Presidente della Repubblica, questo Presidente della Repubblica, facendo in modo che arrivi sulla sua scrivania una richiesta di grazia per iniziativa di chi in tutti questi anni ha avuto il privilegio, dall’interno del mondo carcerario, di essere testimone di una dignità, una forza e un equilibrio fuori dal comune. Un riconoscimento che sia anche riconoscenza per il lavoro svolto come sociologo, per i dati preziosi raccolti in queste pagine.
Per resistere, per mantenere lucidità e autocontrollo, oltre che la salute, il Sociologo ha imparato a scandire le sue giornate come un monaco benedettino: studio, preghiera, esercizio fisico. Addirittura come un anacoreta, un monaco eremita, durante i due anni e passa – «anni due, mesi tre e giorni venti» - di isolamento diurno, ‘‘il silenzio forzato’’, pena accessoria all’ergastolo. Tortura accessoria alla tortura del carcere a vita. Ma a quel punto il peggio era già passato, lui era già strutturato nel fisico e nello spirito come un monaco guerriero. Il peggio erano stati i dodici anni precedenti, a Piazza Lanza prima, il carcere di Catania, e soprattutto a Secondigliano-Napoli, il «lager», gli otto anni più brutti.
Il terrore dei pestaggi, le vessazioni, dodici uomini in venti metri quadrati, lui finito al quarto piano di un castello di letti, a cinquanta centimetri dal soffitto, unico non fumatore nel caldo torrido dell’estate siciliana. Lui che si dà da fare per farsi accettare dagli altri detenuti, che spesso si lasciano andare a sonore risate: «Alessandro, non stiamo ridendo di te, non ti stiamo prendendo in giro. Stiamo ridendo dell’incompetenza di quel giudice che ti ha fatto arrestare e che non ha capito quello che per noi tutti è evidente, ovvero che tu con ‘‘l’ambiente’’ non c’entri proprio nulla.
E dire che per diventare giudice ci vuole la laurea!» Ci si può, ci si deve fidare di questi giudici-psicologi sprovvisti di laurea, e spesso anche di licenza elementare. Non di rado, ma non abbastanza di frequente, succede che i giudici con la laurea riconoscano l’occhio clinico dei criminali analfabeti. Nel mio piccolo posso confermare.
Un vecchio amico di famiglia, Carlo, bollato mafioso perché coinvolto nell’inchiesta cosiddetta Mafia capitale come vicepresidente della cooperatva sociale 29 Giugno, si sentì dire dai mafiosi veri, dai camorristi e dagli ‘ndranghetisti in mezzo ai quali era stato spedito in un carcere di Alta sicurezza in Abruzzo esattamente le stesse cose che si era sentito dire Alessandro vent’anni prima. I giudici di Cassazione, per fortuna, hanno saputo vedere le evidenze che avevano visto i compagni di detenzione di Carlo, invece di secondare i teoremi dei professionisti dell’antimafia.
Che quei giudici senza laurea ci avevano visto giusto è confermato dallo smarrimento del giovane Limaccio, che si sentiva un «intruso», uno «straniero», un «pesce fuor d’acqua». Ma anche un «osservatore», con la voglia, se non la responsabilità di capire quel mondo in cui era stato catapultato. Lo sguardo del sociologo e dell’antropologo diventa precocemente una deformazione professionale nel Sociologo in pectore. Uno sguardo senza odio e senza rancore, ma uno sguardo partecipato e distaccato al tempo stesso.
Del resto, senza quel distacco professionale, che diventa inevitabilmente anche un po’ psicologico, non avremmo le pagine che seguono. «Durante tutto questo tempo ho progettato speso di narrare per disteso i particolari e gli avvenimenti che contraddistinguono ‘‘il mondo carcere’’ […] ma ogni volta vergogna e disgusto me l’hanno impedito». Fino a quando il semplice detenuto è diventato sociologo detenuto. A quel punto il pudore – verso se stesso e gli altri se stesso nei quali da cristiano si è rispecchiato in tutti questi anni - ha lasciato il posto al dovere di documentare e di interpretare.
La carriera di sociologo di Alessandro Limaccio nasce proprio come osservatore ‘‘inviato’’ dalla società civile nelle sue carceri. Come il giornalista embedded o lo studioso in incognito, come quel sociologo di Sabaudia mimetizzato tra i braccianti della pianura pontina o come il sociologo americano Nels Anderson hobo tra gli hobo, clochard tra i clochard, il Sociologo detenuto opera rigorosamente sul campo. Questo volume raccoglie una scelta dell’abbondante materiale raccolto nel corso degli anni di una vita mescolata, come scrive il nostro Sociologo, con quelle degli altri (con)dannati.
A differenza dei suoi colleghi col biglietto di ritorno in tasca – anche se ‘‘aperto’’ - lui opera però senza rete. Biglietto di sola andata. Fine pena mai. Forse per questo un sociologo del genere è ancora più credibile agli occhi dell’umanità sofferente su cui si china, perché lui condivide fino in fondo quella condizione, quelle sofferenze. Lui non può essere sospettato di essere un ‘‘turista’’, uno speculatore. Non è uno di passaggio. Il ricercatore sul campo, si sa, è portato a mettersi al posto dell’Altro. Il testo di riferimento credo sia L’immaginazione sociologica di Charles Wright Mills. Dice Mills che per poter cogliere le rappresentazioni, le motivazioni, i pensieri degli interlocutori, è necessario diventare momentaneamente un altro. È questa reciprocità sociale e umana che permette di costruire un rapporto di fiducia che consentirà a lungo termine di liberare la parola.
Ne ha liberate tante di parole, il Sociologo detenuto, che nelle pagine di questo libro chiama costantemente ‘‘a consulto’’ ora questo ora quel collega sociologo, antropologo, etnologo: le parole di Fabiola la prostituta transessuale brasiliana che sogna di aprire una bottega di parrucchiera nel suo Paese, accusata di tentato omicidio da un suo cliente farabutto; di Leonardo di Manduria, una vita deragliata rimessa sui binari grazie al teatro, vocazione salvifica scoperta in carcere; di Guerino il rom che insegna l’Ave Maria e il Padre Nostro in romané; di Óscar lo spagnolo dislessico e di Humberto l’odontotecnico colombiano che si scandalizza del nostro codice penale fascista, l’uno e l’altro - certifica il Sociologo detenuto - vittime innocenti della Giustizia italiana; di Badr da Casablanca che sogna la California; di Angelo che si porta nella carne e nell’anima le sevizie subite nel manicomio criminale di Aversa; di Giovanni, uscito vivo dal penitenziario di Pianosa (all’epoca ancora non era stato pubblicato Le Cayenne italiane: Pianosa e Asinara. Il regime di tortura del 41 bis, a cura di Pasquale De Feo, 2016).
Fino alle parole di Óscar Alfonso, cileno settantacinquenne, avvocato e docente di Diritto all’università di Temuco, città del Cile centromeridionale, arrestato a inizio anni 2000 nell’ambito dell’ ‘’operazione Condor’’: «Il Pubblico Ministero in Italia mira soltanto ad annichilire e distruggere le persone accusate, esercitando la sua funzione con cattiveria, col fine di annientare moralmente e fisicamente chi è accusato di aver commesso un crimine, anche e soprattutto se contro questi non ci sono prove». Per quanto condivisibile, quasi sacrosanta, un’opinione tra le altre, si dirà. Già, ma al Sociologo non sfugge il valore aggiunto di questa opinione: Óscar Alfonso, chiamato «il generale» dai detenuti di Rebibbia, era un ex tenente colonnello che durante la dittatura di Pinochet era stato procuratore militare con le mansioni di Pubblico Ministero.
***
Dopo più di cinque lustri, il Sociologo embedded in quella periferia del mondo che è l’universo carcerario italiano ha bruciato ogni record di durata di un’inchiesta etnografica sul campo, tutta vissuta in comunione con la sua gente, come facevano certi missionari-antropologi dei secoli scorsi. È ora di chiudere il capitolo, perché c’è un tempo per ogni cosa. Con questo libro, offerto alla comunità scientifica, agli addetti ai lavori, ai suoi compagni e alla società civile, missione compiuta.
Alessandro Limaccio già sa dove andare a vivere quando potrà lasciare la sua cella. Non nella Sicilia di Bernardo Mattarella, e nemmeno nella Roma di Giulio Andreotti. Lui vuole andare a vivere in Trentino. Nel Trentino di Alcide De Gasperi. Un giorno, saputo che io sono mezzo trentino (tramite nonno messinese partito volontario diciottenne nel 1915 «per aiutare i fratelli irredenti di Trento e Trieste», come diceva lui), Alessandro si mise a parlarmi della figlia suora di De Gasperi, Lucia, e del suo commovente epistolario col papà.
Io gli dissi che non conoscevo quelle lettere, ma che in compenso avevo passeggiato in lungo e largo con le mie bambine e la loro mamma davanti la casa in cui Lucia da piccola trascorreva i mesi estivi con la sua famiglia, la casetta in Val di Sella, vicino Borgo Valsugana. A quel punto dovetti promettergli che ce lo porterò in pellegrinaggio appena acquisirà lo status di Sociologo ex detenuto.
E lui, da parte sua, ha promesso alla nipotina Maria Vittoria, folgorata due estati fa dalla bellezza delle Dolomiti, di portare lei e la sorellina Beatrice su e giù per le seggiovie di tutte le montagne del Trentino.



|
é uscito il N° 119 di Quaderni Radicali "EUROPA punto e a capo" Anno 47° Speciale Maggio 2024 |

|
è uscito il libro Edizioni Quaderni Radicali ‘La giustizia nello Stato Città del Vaticano e il caso Becciu - Atti del Forum di Quaderni Radicali’ |

|
è uscito il libro di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo "Napoli dove vai" |

|
è uscito il nuovo libro di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo "l'altro Radicale disponibile |