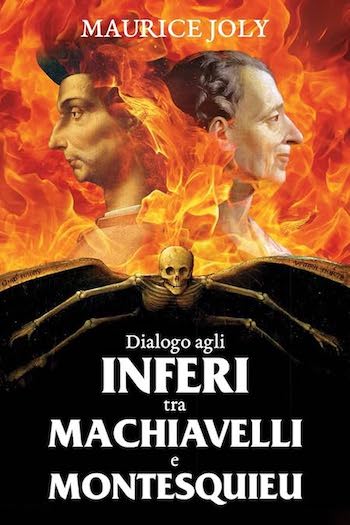


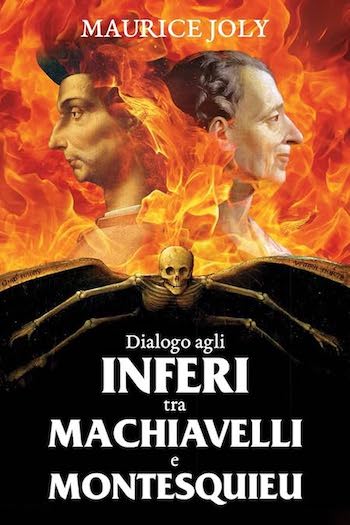
di Enrico Seta
Dopo trent’anni di assenza dalle librerie italiane un piccolo editore (Ibex) ripropone l’opera eccentrica e smagliante di Maurice Joly “Dialogo agli inferi tra Machiavelli e Montesquieu”,che vide la luce per la prima volta nella Francia della metà dell’Ottocento e costò al suo autore la prigione e, in fine, la rovina economica.
L’opera è brillante in quanto ha la forma di un vivace e polemico dialogo filosofico fra i due grandi pensatori politici che ha luogo agli inferi dove (evidentemente) entrambi soggiornano, dotati però della conoscenza derivante dallo sviluppo degli avvenimenti storici fino al XIX secolo.
Il saggio è di perdurante interesse – e quindi bene ha fatto l’editore Ibex a ripubblicarlo – per più di un motivo.
Il primo è la riproposizione di un Machiavelli più reale, cioè ridimensionato nella sua statura di filosofo politico. Tale operazione può avere un alto valore in un paese, come il nostro, in cui il Segretario fiorentino è da almeno un secolo oggetto di un culto quasi religioso, complici le due tradizioni politiche che da allora - ed oggi più che mai - sembrano contendersi il cuore degli italiani: quella di origine idealista nella versione attualista e corporativo-fascista e quella gramsciano-populista.
Fra l’altro, sarebbe oggi altrettanto meritevole del ridimensionamento filosofico di Machiavelli la rilettura della copiosa documentazione comprovante la diretta derivazione della seconda tradizione dalla prima che, come Ruggero Guarini e tanti altri ci hanno raccontato, può leggersi in trasparenza nelle biografie dei più illustri intellettuali gramsciani italiani.
Joly liquida il Machiavelli filosofo con poche battute nelle prime pagine del dialogo immaginario, scolpite dall’interlocutore francese: l’individuazione nella forza e nell’astuzia dei due principi fondativi, autosufficienti ed atemporali, dell’azione politica è solo una tautologia. Che a tali risorse abbiano spesso fatto ricorso i governanti è un dato di fatto che non ha mai avuto bisogno di alcuna dimostrazione sin dai tempi più antichi ma tale constatazione empirica nulla di nuovo ha mai apportato alla filosofia politica poiché non ha indagato dovutamente il nodo filosofico vero: i rapporti fra diritto, morale e religione.
Molti anni dopo il pamphlet di Joly, cioè negli anni ’50 del Novecento, fu un grande pensatore, Leo Strauss, a sottoporre ad analisi critica il pensiero politico di Machiavelli squarciando il velo di stupefatta ammirazione di cui la sinistra intellettuale europea lo aveva adornato.
Ma la lezione di Strauss – nella nostra remota provincia - è per lo più ignorata. Ancora oggi, ne sono certo, molti giovani trarrebbero qualche utilità dal veder dimostrato per tabulas che “non c’è fenomeno morale o politico che Machiavelli conosce o per la cui individuazione è famoso, che non fosse perfettamente noto a Senofonte, per non parlare di Platone o Aristotele” (L. Strauss: Machiavelli in “Storia della filosofia politica” (Vol. II), Il Melangolo, 1995).
Ma se lo studio di Strauss è impresa ormai troppo complessa per i nostri corsi universitari di Scienze Politiche, almeno non lo sia quella dell’agile volume in oggetto. Se non altro per prevenire letture grottesche del Principe, oggi proposte addirittura a sostegno delle più sguaiate tesi pacifiste e filo-Hamas e coltivate anche in ambito universitario (non scherzo! Vedi: Piero Bevilacqua, Discorsi da osteria: Machiavelli e Guicciardini affacciati sul caos, Castelvecchi, 2024).
Fra i due pensatori che l’immaginifico Maurice Joly fa dialogare post mortem agli inferi, ci viene quindi restituita con pochi tratti la differenza di spessore filosofico. Il lettore coglie in maniera vivida la fecondità del contributo di Montesquieu.
Il dialogo, infatti, anche se nell’aldilà, viene collocato in epoca contemporanea all’Autore e quindi, come si è detto, nella metà dell’Ottocento, cioè nella pienezza di quell’età liberale di cui siamo tutti figli e che non solo ha visto dispiegarsi nella realtà vivente dei regimi costituzionali le teorie dell’Esprit des lois, ma ha dimostrato anche che il progresso esiste, e ha sede precisamente nelle istituzioni, e che esso non può che accompagnarsi alla realizzazione – certo non priva di contraddizioni- dei valori dello Stato di diritto.
Appena posta questa solida base – che era poi il convincimento profondo, mai messo in discussione, di un liberale moderato come Maurice Joly – il libro ha un’impennata ammirevole per la sua fantasiosità. Lo spirito di Machiavelli che non accetta la visione pacificata proposta dal francese, con un’audacia di pensiero che neanche i maggiori detrattori osarono mai negare all’autore del Principe, si dà ad una serrata dimostrazione dei punti di debolezza dell’impianto liberale classico e di quelli che possono essere i varchi attraverso cui può insinuarsi, nella fortezza dei regimi costituzionali, un elemento dissolutore.
Il cuore del libro – e il maggiore motivo del suo interesse - è un puntuale catalogo di tutte le falle che potrebbero aprirsi (secondo il serrato ragionamento del Machiavelli di Joly) ma che invece si stanno effettivamente aprendo (sotto i nostri occhi) nell’edificio dello Stato di diritto: lo svuotamento dell’organo legislativo e la cancellazione – nei fatti - del principio di separazione dei poteri, il depauperamento di una stampa libera e anticonformista e la sua progressiva trasformazione in fabbrica di ballons d’essai, l’aggiramento dei principi liberali cardinali in materia di finanza pubblica – in primis il principio di sottoposizione di ogni nuova tassa al voto dei rappresentanti eletti – l’uso abnorme e distorto di informazioni riservate, la continua formazione di un dibattito politico fazioso e deviato su falsi problemi, tutti egualmente effimeri, l’affievolimento lento ma unidirezionale di tutti i diritti politici e sociali del cittadino sanciti solennemente dalle costituzioni liberali.
Nella finzione del Dialogo questo processo disgregativo – che noi contemporanei riconosciamo senza difficoltà – nasce dalla combinazione di spinte populiste – dal basso - e di un’opera incessante di convergenza di interessi ben strutturati. Questa combinazione viene rappresentata come una unica demoniaca intelligenza: un moderno Principe molto più radicato nelle fibre della società contemporanea di quello che - un secolo dopo Maurice Joly - vagheggiò Antonio Gramsci, il quale al confronto con il liberale Joly, ci appare come un ingenuo epigono del più scolorito utopismo idealista.
L’origine di questa attualissima immagine della crisi dello Stato di diritto – che in alcuni momenti assume i tratti di una indolore tirannide strisciante - è nel tessuto stesso di società che hanno portato lo sviluppo economico oltre lo stadio dell’industrialismo dando vita – da un lato - ad enormi accumulazioni di rendita e – dall’altro – ad un popolo che è pronto a perdonare al tiranno qualunque abuso “ma soltanto una cosa ripudia, in realtà: la ricchezza dei propri simili”.
I suoi strumenti non sono la forza e la violenza aperta ma le leggi e i tribunali.
Infine, per i tanti cultori nostrani del Machiavelli (consapevoli o inconsapevoli), il ritratto che ci restituisce Joly, dopo aver sottoposto il pensiero del Segretario fiorentino alla prova storica del dispiegamento dei regimi liberali, ne mostra la natura profonda di sovversivo reazionario – come poi ha persuasivamente dimostrato, ancora una volta, Strauss – e di ideale architetto del colpo di stato strisciante che, in nome del popolo e sempre appoggiandosi alla sovranità popolare, il potere, nelle sue varie forme, tende incessantemente ad ordire all’interno e nelle pieghe dei regimi costituzionali odierni.
Un “divertimento” pieno di spunti sulla crisi della democrazia – come si dice oggi – o, se preferiamo, sulla crisi dello Stato di diritto che è tema imprescindibile non solo per orientarsi nei vasti labirinti del confronto geopolitico che l’Occidente è chiamato ad affrontare nella arena globale, ma anche per uscire dalla finzione del dibattito politico interno dell’Italia meloniana, tra antifascismo, egemonia e e pacifismo, tra bavaglio alla stampa e diritto all’aborto e altre amenità simili.
Come uscire da queste secche senza fare almeno un tentativo di comprendere che fine sta facendo lo Stato di diritto?


|
é uscito il N° 119 di Quaderni Radicali "EUROPA punto e a capo" Anno 47° Speciale Maggio 2024 |
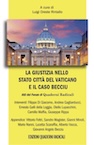
|
è uscito il libro Edizioni Quaderni Radicali ‘La giustizia nello Stato Città del Vaticano e il caso Becciu - Atti del Forum di Quaderni Radicali’ |

|
è uscito il libro di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo "Napoli dove vai" |

|
è uscito il nuovo libro di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo "l'altro Radicale disponibile |