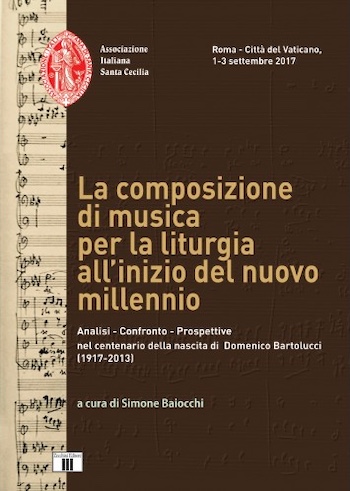



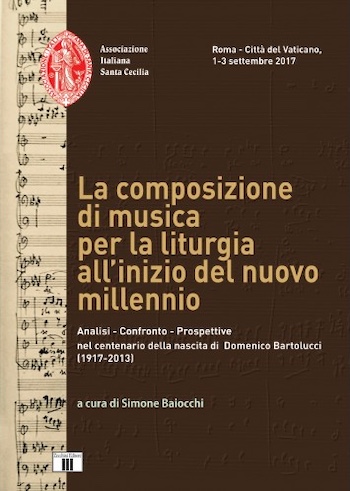
Nel 2017, in occasione del centenario della nascita del compositore e direttore di coro Cardinal Domenico Bartolucci, e a distanza di 26 anni dal primo simposio, si è svolto nella Città del Vaticano il secondo Convegno di musica sacra.
L’evento, al quale hanno partecipato docenti ed esponenti della Chiesa cattolica, non solo ha celebrato la figura e l’opera dell’illustre prelato, ma si è posto come uno degli obiettivi principali quello di mettere in comunicazione gli esperti del settore per analizzare le problematiche della musica liturgica contemporanea e incoraggiare la creazione di nuove composizioni più fedeli ai testi rituali, rispetto a molte delle opere oggi in uso nelle funzioni religiose.
Gli atti del convegno, pubblicati l'anno successivo da Zecchini Editore, sono stati arricchiti dalla prefazione del giornalista vaticanista RAI Aldo Maria Valli.
Negli ultimi secoli e fino a tutto l’Ottocento, il compositore di musica sacra era spesso un maestro di cappella al servizio di un committente, non sempre legato alle celebrazioni liturgiche. Non era necessario avere un diploma specifico e, anche se “non aveva particolare dimestichezza col mondo liturgico e con le sue pratiche musicali bastava che si guardasse intorno: esempi a cui ispirarsi e magari da imitare ce n’erano in abbondanza.”
Oggigiorno, invece, in molte chiese le melodie e i canti sono ritenuti inadeguati, perché “mancano i poeti, i parolieri, gli autori, coloro che preparano un testo da vestire in musica con dignità”; testo che dovrebbe invece “rispondere a criteri strettamente liturgici”. Una critica molto severa questa, condivisa da tutti gli intervenuti.
Di conseguenza, è stato sottolineato, la musica sacra non può essere improvvisata o affidata a compositori privi di una solida ispirazione spirituale, ma dovrebbe essere creata da coloro che “hanno una preparazione assoluta, che si fondi su uno studio serio delle tecniche compositive unito ad una conoscenza il più possibile ampia della letteratura musicale di ogni epoca.” “Nelle funzioni – ha affermato un relatore - dilaga un atteggiamento populista”.
Alcuni canti, infatti, risulterebbero essere più adatti a un festival come Sanremo che a una chiesa e talvolta arriverebbero perfino a sfiorare la blasfemia, poiché mancherebbero di qualunque riferimento al sacro. “Spesso – secondo Mons. Valentino Miserachs Grau, organista della Cappella Giulia in Vaticano, docente di composizione al Conservatorio di Matera e preside emerito del Pontificio Istituto di Musica Sacra – confondiamo il funzionale con l’utile o, peggio ancora con l’utilitarismo. (…) Il canto gregoriano rimane pur sempre, oltre ad essere il canto proprio della Liturgia romana, un valido esempio di funzionalità liturgica.”
I lavori sono stati aperti da Suor Rosemary Esseff che ha tenuto una dissertazione sul linguaggio e le tecniche musicali di Bartolucci attraverso l’analisi di alcune sue composizioni.
Mauro Visconti, invece, si è concentrato sull'auspicio di un maggiore coinvolgimento di vescovi, sacerdoti e responsabili degli uffici liturgici, affinché possano offrire maggiore supporto nell'investire nella formazione del clero.
Don Valentino Donella, direttore del Bollettino Ceciliano e direttore emerito della Cappella Musicale di Santa Maria Maggiore, ha illustrato il percorso storico della composizione nelle forme e nei generi, sottolineando come, con la riforma liturgica del 1963, la composizione musicale sia diventata una vera e propria specializzazione. In quel periodo, inoltre, con il Concilio Vaticano II cambiò anche la lingua dei testi liturgici, che passò dal latino all’italiano.
Michele Manganelli, allievo di Bartolucci, dopo aver trattato dell’evoluzione del linguaggio musicale e del suo mutamento nel tempo, ha analizzato i corsi di laurea e i metodi didattici del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Citando Bartolucci, Manganelli ha sottolineato che “Il cantore è un predicatore in musica”.
Nonostante la forte disapprovazione delle prassi più diffuse oggigiorno i relatori hanno espresso la speranza che la situazione possa migliorare, rimuovendo un “repertorio scadente” e sostituendolo “con uno antico e nuovo, degno, comunque, di servire il culto divino”.
A chiusura del volume, sono riportate brevi biografie di ogni conferenziere.


|
é uscito il N° 119 di Quaderni Radicali "EUROPA punto e a capo" Anno 47° Speciale Maggio 2024 |
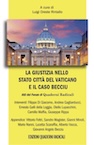
|
è uscito il libro Edizioni Quaderni Radicali ‘La giustizia nello Stato Città del Vaticano e il caso Becciu - Atti del Forum di Quaderni Radicali’ |

|
è uscito il libro di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo "Napoli dove vai" |

|
è uscito il nuovo libro di Giuseppe Rippa con Luigi O. Rintallo "l'altro Radicale disponibile |